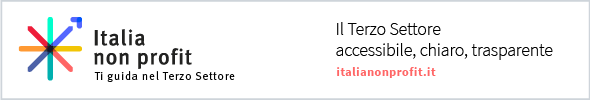Lo choc dell’arte contemporanea
Che cos’è l’arte? Grazie a Duchamp lo sappiamo: potenzialmente tutto. Chi fa arte? Grazie a Beuys lo sappiamo: potenzialmente tutti. Dove si trova l’arte? Da quando c’è internet ci è chiaro: potenzialmente ovunque. Resta solo da chiedersi se l’arte non abbia esaurito il suo compito di forma vitale, fonte di pensiero e serbatoio di stimoli visto che una volta ricercava l’aspetto particolare e non banale e poi è stata costretta a perderlo nel corso della rivoluzione estetica degli ultimi cento anni. Adorno lo chiama lo «choc».
Nell’introduzione al volumetto del 2001 Das Altern der Moderne (L’invecchiamento della modernità) Peter Bürger, rifacendosi al saggio di Adorno sull’avanguardia musicale del 1973, ha intrapreso un tentativo di discussione critica: «La modernità artistica non ha forse perso un po’ della sua grinta nei confronti degli avversari?». Tentativo rimasto senza risposta. Il suo attacco all’arte moderna è fallito perché all’autore mancava la passione, fondamentale per quell’aspetto di follia dell’arte contemporanea in cui ci si trova a sguazzare quando tutti i confini sono superati; un po’ come Daniel Buren che negli anni Sessanta usava le strisce come strumento per analizzare la nostra capacità di percezione, ma che per Bürger erano «pezzi di stoffa» e basta. Quando si parla di realtà e di effetti è sempre una questione delicata. Anche se Bürger non fa parte del gruppo dei posseduti dall’arte contemporanea, la sua domanda era senz’altro giustificata e necessaria in quanto provocatoria. E lo è ancora oggi.
Soffocata dagli antichi maestri
Mai come oggi l’arte è stata raccontata dal suo interno alla società così volentieri. Nel solo mese di settembre abbiamo assistito all’apertura di un numero incredibile di biennali d’arte in tutto il mondo, da quella cinese di Chengdu a quella di Lione, dal titolo «Une terrible beauté est née»; poi la Biennale di Mosca curata da Peter Weibel con «Rewriting Worlds», Istanbul, con la sua programmatica biennale «Untitled», la sorprendente biennale di Pechino e infine, cuore di tutte le biennali, quella, già aperta da giugno, di Venezia, dove l’esoterismo caratterizza l’esposizione «ILLUMInazioni» curata da Bice Curiger. Gli artisti esposti non si contano, le ripetizioni sono consuete, ma consapevoli. L’arte contemporanea partorisce a velocità sorprendente un canone di cultura.
Visitando le biennali si rafforza questa impressione: l’arte contemporanea ha smarrito il senso del presente. Si procura testimonianze dall’arte moderna o scomoda gli antichi maestri perché ci spieghino che cosa significa la parola «contemporaneità». A Venezia tre giganteschi dipinti di Tintoretto hanno avuto il compito di spiegare l’aspetto attuale e visionario del nostro panorama artistico contemporaneo. L’arte contemporanea viene così soffocata in tal modo che può solo dispiacere, cosa che non giova neanche alle opere dello straordinario pittore Jack Goldstein. A Lione Alberto Giacometti viene sorprendentemente mescolato ad altro: i suoi ritratti sono appesi in una sala accanto ai grotteschi volti color pastello di Marlene Dumas e ai lunghissimi fili di lana di Cildo Meireles che rendono difficoltoso il passaggio e terminano all’angolo nello spazzolone di una scopa. Perché l’arte contemporanea è così poco consapevole di sé? O forse questa commistione è il segno che stiamo passando in una nuova era?
Servono sforzi di riflessione
Quando nel 1991 fu inaugurato il Museum für Moderne Kunst, il Museo d’arte moderna di Francoforte, c’era fame di arte, di attualità. Allora dominava la credenza, supportata da insegnamenti di simulazioni e semiotica di ogni genere, che il presente fosse ben distinto dal passato perché radicalmente diverso, anzi che il presente richiedesse tutt’altro genere di concetti: in effetti il nostro tanto venerato presente è diventato passato in modo tanto repentino quanto banale, come l’arte moderna, Picasso, Duchamp e anche Warhol, o ancora, pensiamo agli slogan coloriti di Barbara Kruger che passavano per innovativi per la velocità con cui venivano compresi, come «It’s a small world, but not if you have to clean it» del 1990. Queste battute fulminanti suonano oggi come uno scherzo logoro. L’era digitale, tuttavia, pretende che coloro che vi operano si adoperino per un simile sforzo di riflessione anche nel senso di una rivalutazione del presente.
Che aspetto ha oggi il presente da un punto di vista sociale? La scorsa primavera è stata esposta a Dubai l’opera di un artista egiziano che rappresenta un manifesto di Mubarak mentre viene strappato da un ragazzo, il quale, a sua volta, indossa una maglia con l’emblema di Facebook. Pittura, Facebook, Mubarak si fondono uno nell’altro e danno vita a una bella e grande confusione. L’arte si pone di fronte a questa selvaggia mescolanza, a questo sfibrato qualcosa, e non capisce che non può esistere un «aldilà» di questo mondo digitale: il suo compito, ce lo hanno insegnato Marshall McLuhan e Jean Baudrillard, è quello di opporsi criticamente a questa superficie, esercitando una critica per immagini, cosa che oggi, dal di fuori, come avversario, è impossibile fare. Perché bisogna agire dall’interno. Da quando l’arte ha interiorizzato la propria storicità riconoscendosi come «moderna», le ostilità tra pittura e fotografia, installazioni e scultura sono sempre inevitabilmente anacronistiche, poiché tutto esisteva già una volta, prodotto artificialmente per dare giustificazione all’esistenza e all’azione.
Non c’è posto per gli animi sensibili
Alla Biennale di Venezia si è distinto l’artista belga di installazioni, performance, video Angel Vergara, che ha esposto l’opera dal simpatico titolo di «Feuilleton» nel padiglione nazionale. Al suo interno vediamo su grosse tele pagine in movimento di noti giornali in bianco e nero che una mano con un pennello tenta incessantemente di afferrare, mentre su una superficie di vetro sovrastante l’artista dipinge cercando di imitare i movimenti. Il risultato è un dipinto astratto in colori impressionistici su lastre di vetro. Questo maldestro tentativo di stare al passo in qualche modo con il mondo dei media corrisponde al tentativo dell’arte di cercare un’evoluzione invece di basarsi sulle proprie forze dopo averle trovate.
Un esempio simile era dato dal padiglione svizzero, zeppo all’inverosimile di roba. Thomas Hirschhorn vi aveva creato, e lo si notava subito, un universo contemporaneo del tutto sconsigliabile agli animi sensibili. Dal punto di vista tematico si dimostrava molto attuale: attorno ad attrezzi ginnici impacchettati in fogli di alluminio e sedie da giardino ricoperte di telefonini si srotolavano metri di nastro adesivo a cui sono appese migliaia di fotografie dall’argomento «nefandezze da tutto il mondo».
Queste immagini sono di una brutalità senza pari. Mostrano tutto ciò che per riguardo ci viene risparmiato dai media: teste dilaniate dalle bombe, la realtà della guerra dietro la facciata mediatica. Dopo soli quindici minuti trascorsi in compagnia di questo orrore in cui ci si sente confusi e desiderosi di uscire, tormentati dallo spettacolo crudele di cervelli scoperchiati, si ritrovava all’esterno il sollievo catartico di non dover più assistere a questa pazzia. Anche questo è un aspetto della nostra quotidianità. Ma come arte del XXI secolo? Non è che la replica di tutti i contenuti che possiamo facilmente richiamare navigando in internet.
Arte d’esportazione per Mosca
Pochi metri più avanti ci allietava la vista del più innocuo approccio del padiglione danese che esorcizzava anch’esso il tema politico con l’esposizione di gruppo internazionale di «Revolutionary Free Speech». Tutto molto politico, quindi; è dunque questo il nuovo modo di intendere il «contemporaneo» come politico? Negli ultimi dieci anni l’arte contemporanea si è palesemente politicizzata o, per meglio dire, si è lasciata trasportare a riprodurre temi politici con una immediatezza che non era possibile nell’arte politica degli anni Sessanta e nella quale l’aspetto politico veniva interpretato come esortazione all’azione, e l’arte come campo di sperimentazione di un’altra società.
È dunque questa la soluzione? Peter Weibel, direttore dello Zkm, Centro per l’arte e le tecnologie mediatiche di Karlsruhe, nonché ex artista, ha traslocato a Mosca la sua arte contemporanea che da là avrebbe dovuto «riscrivere mondi». Una bella pretesa. Aristarkh Chernyshev e Alexei Shulgin (il duo di artisti russi noti come Electroboutique, Ndr) hanno subito appeso all’ingresso una grande croce ricavata da un tabellone elettronico aeroportuale, «Big Talking Cross» (2011). Questo simbolo religioso, legato al pericolo del volo, era, nel 2011, nient’altro che un ricordo dell’11 settembre 2001. Un tema di questo tipo, però, paradossalmente annulla il riferimento al presente perché molto rapidamente diventa storico, cioè il contrario di attuale, perché al tempo della «rete» la velocità diventa impressionante.
Lo sappiamo tutti e ne siamo anche un po’ annoiati. Non è neanche una scusa. L’arte è sempre stata in grado di superare questi ostacoli. Non è improbabile che a posteriori ci accorgiamo che l’arte, a differenza della letteratura e della filmografia, ha fatto una svolta attorno al nocciolo della questione, cioè l’esistenza dei cambiamenti all’interno della nostra società (come dopo il 1989 con la fine della Guerra Fredda e la riunificazione della Germania), che ha spostato l’arte in un rapporto di tensione culturale ed economica, come Philip Ursprung ha appropriatamente osservato, seguendo il motto di Beuys «I like America and America likes me». Nessun presente senza storia, senza presente nessuna possibilità di far riferimento al passato.
Jeff Wall e il ritorno del realismo
Come forma e contenuto o estetica e politica, così anche queste due grandezze temporali si trovano in un rapporto di dipendenza reciproco che viene attraversato artisticamente da meccanismi di mercato, critica e organizzazione di mostre e gallerie, che isolano il campo artistico così come le crisi sociali nel mondo disperdono le comunità. Come può l’arte superare queste divisioni, come deve operare per ricomporre gli aspetti contrastanti in una visione generale più avanzata?
Nel 1956 Richard Hamilton compose il suo collage «Just What is it that Makes Today’s Homes so Different, so Appealing?», pescando a piene mani dal nuovo materiale del mondo variopinto e sconosciuto delle riviste illustrate. La grande risorsa fu il presente impazzito della fine degli anni Cinquanta e dei Sessanta: l’artista ne risucchiò lo spettacolo tecnico e sociale e lo mise nel suo visionario lavoro. Circa vent’anni dopo Jeff Wall divenne famoso con la sua lightbox «The Destroyed Room»: con la messa in scena perfetta della fotografia Wall si è rifatto al realismo, con qualche riferimento al linguaggio pubblicitario.
Nel frattempo, con mezzi tecnici ancora una volta diversi, Dan Graham creò il suo presente: usando una videocamera provò i confini e le possibilità del nuovo mezzo e mostrò all’osservatore dentro cubi di specchi il gioco del guardare e del guardarsi. Nel 1991 il cubano Félix Gonzáles-Torres trattò l’inesorabilità del virus Hiv con il suo letto fotografato in pubblico, come cartellone pubblicitario, con le impronte lasciate da chi vi aveva dormito. La sua opera ha costituito un punto di partenza per la Biennale di Istanbul per essere riuscita a mischiare l’aspetto personale con la politica in una forma artistica e mediatica.
Il mondo dell’arte mantiene la posizione
Anche oggi i media trepidano perché la base sociale trema. Ma non è così semplice astrarre da ciò le scelte mediatico-artistiche. La fotografia ha accettato la competizione con la pittura e contemporaneamente la pittura del ventesimo secolo segue l’esempio della fotografia. Dopo sono arrivati i video e ora anche la rete. L’immagine in movimento diventa il feticcio del mondo dell’informazione e i contenuti socio-artistici non si divulgano in televisione, ma attraverso YouTube e Facebook.
Tuttavia il mondo artistico difende inesorabilmente, ancora nel 2011, il terreno conquistato, mentre il resto del mondo soggiace alle nuove segregazioni organizzate e comunicate per via digitale tra vecchio e nuovo, forma e contenuto, notizia e opinione. L’arte contemporanea attira il fallimento come la luce gli insetti. Proprio perché deve essere nuova, diventa presto obsoleta. Ai tempi in cui il cosiddetto Classico moderno veniva accettato dalla critica colta come concetto, esistevano ancora categorie come quella di trovarsi in contraddizione con la sua idea e quindi di perdere la propria conformità e sostanzialità estetica.
Bricolage informatico
Ormai quei tempi sono passati. L’arte contemporanea si è manifestata, ha le sue grandi figure che continuano a valere. «Il pericolo dell’assenza di pericolo» non è più un tema attuale, se non nella pura massa. L’arte oggi è libera da numerosi vecchi legami, si è rimessa a nuovo, come il mercato globale dell’arte e le sue regole severe. Ogni nuovo limite torna a ispirare il gioco delle trasgressioni, gioco che non può riguardare esclusivamente il concetto di contenuto, ma deve ispirare anche una certa temerarietà formale. Nuove macchine come i computer offrono anche nuove possibilità di ribellarsi in modo mirato alle istruzioni per l’uso.
Il fai da te dell’arte politica
Purtroppo però l’arte del computer si adatta fin troppo a queste istruzioni per l’uso e si trova a essere o troppo distaccata tecnicamente o esteticamente troppo goffa. Esisterà mai un «Nudo che scende le scale», un Ulisse o una «Notte trasfigurata» dell’era digitale? No, fintanto che si rimarrà impantanati nell’apparato digitale e in un’atmosfera retrofuturistica.
L’arte di genere politico, invece, va nella direzione opposta, verso un fai da te specializzato dei feticisti del computer (esiste naturalmente una certa varietà di produzione artistica nata nel 2011 al di fuori di queste categorie, ma non è necessariamente contemporanea). È tuttavia sorprendente come da essa ci si aspetti sempre che possa riprodurre la realtà, mentre è solo un ombrello di algoritmi e flussi di dati che tutto copre: la vecchia verità lapalissiana che le immagini mentono.
Tutto è nero
Su questa verità si fonda il lavoro che l’artista di video israeliano Omer Fast ha presentato alla Biennale di Venezia. L’autore del film ci fa vedere dall’alto la città di Las Vegas immersa nelle sue luci scintillanti. Ci accorgiamo allora di essere seduti su un drone che si sta dirigendo verso un grattacielo: in «5000 Feet is the Best» del 2011 la voce fuori campo del pilota ci illustra le strategie del suo lavoro. Che questo pilota in realtà non sia nient’altro che un attore, ci riporta ancora una volta sul tema noto della sfiducia nei confronti delle immagini. Ma basta per definirla arte contemporanea?
L’argomento sembra chiuso a partire dalla «picture generation» di Barbara Kruger, Cindy Sherman, Robert Longo o Richard Prince. Ma dobbiamo fare un passo avanti. Entriamo in uno spazio completamente buio al Kunst-Werke di Berlino nella mostra «Seeing is Believing» e a tentoni procediamo. Tutto è assolutamente nero. Tutto, semplicemente. La vista si abitua lentamente, riconosce una scala, delle barre in lontananza. Con le braccia tese in avanti, azzardiamo ogni passo, come un cieco che sale una montagna. Poi, gradualmente, i contorni si svelano: barre, casse, attrezzi, acciaio.
Mostruoso, eppure innocuo
Cominciamo a riconoscere la parte posteriore di un camion. È carico, manca il telone di copertura. Osiamo sempre di più, ci fidiamo a girargli attorno, lo tocchiamo, vorremmo salire e guardare, ma non è possibile. L’oscurità rimane, ma ora l’occhio si è abituato e riconosce tutti i contorni. Lasciamo la sala con passo sicuro, senza sapere bene che cosa abbiamo visto. Un camion enorme, con un carico sconosciuto in un luogo buio. L’artista spagnolo Iñigo Manglano-Ovalle ha costruito il suo «Phantom Truck» nel 2007 basandosi su una fotografia satellitare dell’esercito americano.
La fotografia doveva provare che l’Iraq possedeva laboratori mobili di armi biologiche e giustificare così l’attacco degli Stati Uniti di fronte al Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Ma quanto più ci si sofferma sulla mostruosa silhouette, tanto più appare innocua. L’esistenza di armi biologiche in Iraq non è mai stata provata. Ci ricordiamo di Guernica perché esiste il quadro di Picasso. «Phantom Truck» non è più esposto a Berlino.
Che cosa ci comunica questa arte? Lo stimolo deve prescindere dagli accessori formali, altrimenti l’artista avrebbe dovuto distribuire anche un volantino per spiegare in modo preciso e dettagliato tutti i contenuti razionali. Allora, in che categoria rientra questo camion, illustrazione di un avvenimento noto o arte di rilevanza sociale? Quest’opera esprime fortissima contemporaneità, l’approccio dell’artista al mondo non è senza pretese. «Socialmente rilevante» qui non significa l’elaborazione della questione sociale, ma, e l’opera lo dimostra, stabilire un rapporto tra arte e pubblico. Ma come invecchia facilmente tutto ciò: quattro anni dopo il motivo è già un argomento di soggetto storico, per quanto istruttivo. Tuttavia, come nel caso del famoso dipinto di Manet «L’esecuzione di Massimiliano» del 1868, col passare del tempo anche gli spazi vuoti forniscono a un’opera contenuti importanti.
L’arte, forza in movimento
Le espressioni artistiche hanno grande peso all’interno della nostra società. Ci sono più persone che vanno al museo che non allo stadio. Il problema è la segregazione come somma di calo di credibilità, mancanza di movimento, pericolo di qualunquismo. Non esiste un «aldilà» della simbolicità digitale, ma ciò che viene mostrato riguarda tutto, non solo l’estetica.
L’arte non può restare indifferente, così come i suoi temi, il suo pubblico, i suoi intermediari. Io non sono del tutto convinto che l’arte da sola possa cambiare l’umanità; sono invece convinto che colui che vuole cambiare qualcosa debba fare ricorso non solo a strumenti politici e intellettuali, ma anche estetici, che stanno chiedendo a gran voce una critica pratica.
Chi vuole rispondere?
© Riproduzione riservata
Traduzione di Cristiana De Dominicis
di un articolo pubblicato dalla «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 12 novembre 2011
© Frankfurter Allgemeine Zeitung. All rights reserved. Provided by Frankfurter Allgemeine Archiv