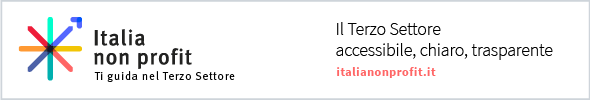Le fondazioni possono fallire?
Una recente sentenza della Corte d’Appello di Venezia riporta il dibattito sul possibile fallimento delle fondazioni. Abbiamo richiesto un parere in merito al prof. Francesco Florian
L’Italia non è un paese di common law e quindi una sentenza del giudice di merito è una sentenza uguale solo a se stessa. Far quindi derivare dalla pronuncia n. 1801/15 della Corte d’Appello di Venezia il principio generale della sottoposizione anche delle fondazioni al fallimento, pare essere quantomeno frettoloso e non costituisce peraltro nemmeno una novità.
Che i cosiddetti enti non profit possano svolgere attività economica è infatti pacificamente ammesso e che qualora detta attività sia esercitata in via prevalente, professionale, organizzata e stabile li esponga alla possibilità del fallimento, non è conquista degli ultimi tempi.
Del resto gli stessi giudici veneziani nella loro pronuncia sono filologicamente rigorosi e chiari e certamente non affermano il principio secondo cui lo svolgimento di attività economica in via strumentale possa costituire presupposto per l’applicabilità della legge fallimentare, qualificando l’ente quale imprenditore, né che quella stessa attività svolta in via prevalente debba/possa presuntivamente avere quelle caratteristiche di professionalità o stabilità che, tra le altre, provocano il fallimento dell’ente non commerciale.
In altri termini, occorre la concorrenza univoca, precisa e concordante (e direi continuativa) di una serie di presupposti tipici dell’attività imprenditoriale perché si possa arrivare alla estrema conseguenza del fallimento. Ciò che, casomai, può colpire prima facie è la circostanza che stiamo vertendo in tema di enti che non possono distribuire utile, laddove una impresa esercitata in forma societaria vede la distribuzione dell’utile quale sua propria cifra genetica. Orbene, la non distribuzione dell’utile non può assurgere a parametro assoluto che scarti l’applicabilità del fallimento agli enti non lucrativi (in senso soggettivo). Se, infatti, realizzo e distribuisco scarpe utilizzando una associazione, non per questo non svolgo una attività imprenditoriale pura che, anzi, pare pure lesiva, rispetto alla stessa attività esercitata in forma di impresa commerciale, del principio di leale concorrenza. E sul tema anche il mondo del non profit dovrebbe porsi in maniera rigorosa.
Non mi pare che la sentenza veneziana si scosti da questa cornice di riferimento; né mi pare che affermi che la sottoscrizione da parte di una fondazione di un contratto di ricerca ne provochi il fallimento, come pure una attività di fund raising; né mi pare sostenga che lo svolgimento in via strumentale di attività d’impresa (sfruttamento di un marchio/brevetto, anche per il tramite di società collegate, a meno che l’attività della fondazione non sia solo quella di gestione di partecipazioni) provochi la medesima conseguenza; né ancora mi pare arrivi a sancire che lo svolgimento in via prevalente della citata attività sia di per se un indice incontrovertibile e insuperabile ai fini della sottoposizione alle procedure fallimentari, se non sia assistito da precisi e continuativi indici di bilancio, pure riscontrabili nei “conti” dell’ente.
In buona sostanza, la Corte veneziana conduce una analisi complessa e sistematica di un quadro operativo della Fondazione tale da non lasciare dubbi circa la sua configurabilità in concreto ed in actis quale imprenditore commerciale. E’ quindi opportuno sottolineare con forza come i giudici si siano pronunciati su un unicum per ciò stesso definito e non estensibile in via analogica.
L’aspetto che non mi sembra sufficientemente colto dai primi commenti alla sentenza è l’origine della Fondazione nel caso de quo. Essa, infatti, è stato l’istituto adottato dai soci quale esito di un’operazione di trasformazione eterogenea. Si legge infatti chiaramente nella sentenza che la Fondazione traeva la sua origine da una società a responsabilità limitata (da qui la parte della decisione che afferisce ai termini di opposizione) che aveva deliberato la propria trasformazione in fondazione. Ora, la trasformazione eterogenea è fenomeno successorio volto a garantire la continuità dell’azienda. Con l’entrata in vigore del (ormai non più) nuovo diritto societario è infatti possibile la trasformazione di società di capitali in fondazioni come pure il contrario. Il tutto alla luce del principio di continuità dell’impresa, intesa come “intrapresa”, sia essa culturale o scientifica.
Orbene, tale opportunità fornita dall’ordinamento non consente impieghi distorsivi o abnormi, però (anche perché alla lunga non tengono). Mi spiego. Se sono in presenza di una società a responsabilità limitata in stato prefallimentare perché ha eroso, ad esempio, il capitale sociale oltre i limiti consentiti dalla legge, non vale, ad escludere il fallimento, la sua trasformazione in fondazione, sulla base della considerazione che quello stesso capitale eroso ed il complesso patrimoniale assicurano il minimo di fondo di dotazione necessario per il riconoscimento. Né serve ad escludere l’applicazione della procedura fallimentare la presenza di un capitale esistente nel suo minimo legale risiedendo il dissesto altrove.
E ciò si badi sulla base di due circostanze. In primis, il fatto che, più o meno efficacemente, il nostro ordinamento reagisce agli abusi di diritto; in secundis, perché tecnicamente mediante il procedimento di trasformazione eterogenea si assiste al trasferimento della medesima situazione patrimoniale ed economica dell’ente trasformando in quello esito della trasformazione, con il che è ben difficile elidere giuridicamente situazioni che giuridiche non sono. Mi si perdoni un esempio folcloristico: se sono alto un metro e novanta, che mi metto una giacca di tweed o una di lino, sempre un metro e novanta sono; se però son uscito di casa vestito in tweed perché pensavo fosse freddo ed invece è caldo, allora cambio giacca, mettendo quella di lino, ma sempre un metro e novanta sono. Questo mi consente il codice con la trasformazione eterogenea: cambiare veste giuridica alla mia intrapresa in continuità con la stessa.
Non si può non leggere la sentenza della Corte alla luce di questo suo profilo costitutivo e, quindi, senza aver ben contestualizzato l’elemento primigenio della fondazione dichiarata fallita che è la sua provenienza da un ente tipicamente e classicamente commerciale, tanto sotto il profilo del lucro oggettivo quanto sotto quello del lucro soggettivo (statutaria distribuzione dell’utile).
Affermare perciò ciò che la Corte non fa e cioè che tutte le fondazioni possono essere esposte al fallimento mi pare grossolano (e mi scuso anticipatamente per questa espressione forte), anche perché significa economicizzare, bancarizzare e fiscalizzare il Diritto che è cosa ben diversa dal concepire la norma giuridica quale strumento per e dell’economia sana. Processo, il primo, che -sebbene purtroppo talvolta accada- è doveroso allontanare perché «fatti non fummo a viver come bruti».
© Riproduzione riservata
Francesco Florian
Università Cattolica, Milano