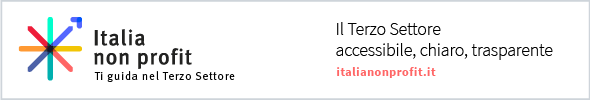Il museo del Ventunesimo secolo
Se si dovesse procedere ad una riflessione aggiornata sul concetto di Museo, oggi, considerando tutte le evoluzioni in corso si arriverebbe piuttosto facilmente a sostenere che esso non serve solo a raccogliere, conservare, studiare, documentare, ma soprattutto a mostrare, a creare contatto, e come proverò a dimostrare è uno strumento di coesione e coestensione sociale, e concorre a produrre conoscenza.
Questi aspetti sono molto chiari nei documenti internazionali sottoscritti dal nostro paese in ambito culturale (la lista è lunga, l’ultimo in ordine di tempo, ancora in attesa di ratifica, è la Convenzione di Faro del 2005), il cui approccio è completamente capovolto rispetto a quello ancora dominante da noi; in breve, ed in piena coerenza con l’impianto costituzionale italiano, essi antepongono la persona e le sue esperienze a tutto il resto anche per ciò che riguarda le politiche culturali, e dunque suppongono che il vero, ultimo scopo del complesso lavoro riguardante i prodotti culturali sia quella che nel nostro linguaggio domestico è chiamata la fruizione.
Come chiunque ne fa esperienza può testimoniare, infatti, la frequentazione abituale con i prodotti culturali, specie quelli di valore, aumenta la ricchezza di chi la vive, ne amplia le idee, la capacità di concetto, le intuizioni, gli argomenti, e dunque migliora, o comunque rende più complesso il suo pensiero e di conseguenza il suo discorso, abituandolo a considerare l’altro da sé come interessante e, almeno, degno di rispetto. Quanto più dunque si favorisce questo contatto, quanto più esso è ampio, numeroso, variegato, tanto più questi vantaggi si fanno pubblici, collettivi, declinandosi in forme di coesione sociale e di miglioramento della convivenza, in capacità di creazione, innovazione e dinamismo economico e produttivo, persino in miglior funzionamento delle istituzioni democratiche. Non è un caso che sia in ambito OCSE che, ultimamente, anche in Italia, ha preso consistenza la misurazione della qualità oltre che della quantità della ricchezza di persone e nazioni (si pensi al Better Life Index, in chiara alternativa, o quantomeno in aggiunta al PIL, ed all’italiano Bes, promosso da ISTAT e CNEL).
Abbiamo in effetti accumulato nuove ed aumentate conoscenze circa la connessione tra cultura e sviluppo economico, abbiamo capito che non è dovuta ai soli impatti turistici, o agli usi elitari dei beni culturali; comincia ad essere chiaro quanto la produzione culturale sia centrale per le condizioni di sviluppo economico e sociale di medio e lungo periodo, per la crescita del “capitale umano”, per la sempre più chiara “culturalizzazione” della vita economica e dei processi identitari, per l’utilità del concetto di capabilities. Stiamo comprendendo sempre meglio che creatività e cultura sono vere e proprie "palestre dell'innovazione" in ogni settore economico, industriale e produttivo, e che idee nuove, arricchimento ed utilizzo aggiornato delle tradizioni, uso attuale del conosciuto, si alimentano di fruizione culturale. Ma dobbiamo trarne le conseguenze, ed immettere contenuti culturali nelle strategie di redistribuzione, con interventi di contatto quanto più ampio con i prodotti culturali e volgere tutto all'allargamento della fruizione, dando per scontato che ciò può avere effetti di reciprocità sulla tutela.
Scrive Amin Maalouf, in un suo bel libro dedicato all’identità, che «sarebbe persino desolante per un popolo, qualunque esso sia, venerare la propria storia più che il proprio futuro». Niente di più vero, che però ci impone una seria riflessione, tra altro, sulla definizione medio novecentesca di “bene culturale” recata dalla normativa vigente, che fa ben emergere i valori di attestazione che i prodotti culturali recano con sé, dote tuttavia pensata molto per le cose, e soprattutto per quelle provenienti dal passato, mentre appare più sfumata, quasi casuale, per le cose ed i fatti recenti, per quelli dell'oggi, e per quelli la cui capacità documentale è più complessa, non foss'altro che a motivo della loro struttura de-materializzata.
Questo incedere con lo sguardo sullo specchietto retrovisore produce anche la sostanziale uniformità del regime giuridico dei beni culturali, indipendentemente dalle notevoli diversità, invece, delle tante cose, dei tanti comportamenti, dei tantissimi materiali e supporti, dei tanti allestimenti e delle tante percezioni che formano il variegato universo dei prodotti culturali. E induce a tenere separato tutto ciò che proviene dal passato da ciò che viene prodotto oggi: siamo nani che camminano sulle spalle dei giganti, ma dobbiamo provare a continuare a diventare giganti per i nani che verranno domani, e consentire loro di ingigantirsi.
Forse è giunto il momento di invocare una riflessione aggiornata sul concetto di bene culturale, una “commissione Franceschini (nomen omen?) per il XXI secolo” che riesca a far emergere la dinamica, l’energia sempre attuale ed utile all’oggi dei valori culturali di ogni tempo, orienti ogni lavoro che vi sia dedicato alla fruizione, e non perda la opportunità di regimi giuridici differenziati in ragione delle diversità di fruizione dei "oggetti culturali", consentendo più agilmente di dispiegare i propri effetti, anche di impatto industriale ed economico, ai valori culturali insiti nelle attività performanti e di recente o contemporanea produzione.
Dobbiamo poi tener conto della situazione istituzionale del nostro Paese, molto mutata anche in ambito culturale negli ultimi anni; il ruolo dei governi regionali e locali è enormemente aumentato, cominciano ad avere organizzazioni attrezzate con sufficiente affidabilità, una parte consistente del budget pubblico per la cultura è ormai a carico dei loro bilanci, molte Regioni sono dotate di discipline settoriali specifiche, si sono sperimentate diverse formule gestionali, tra sistemi, reti, distretti e fenomeni altrimenti denominati, caratterizzati tuttavia dall’alleanza tra diversi attori del territorio nel produrre investimenti e gestioni.
La fotografia reale, territoriale del paese ci restituisce un’immagine molto diversa da quella stereotipa anche in ordine alla questione che in linguaggio corrente continua a definirsi dei “privati” e del loro ruolo in cultura, figure molto numerose e diverse che non vanno accomunate e confuse nel variegato universo dell’“industria” riguardante la cultura, dove va guardata con attenzione la distinzione, sempre più rilevante in questo come in altri segmenti, tra attività profit e non profit, cui di recente si sta aggiungendo la interessante esperienza delle attività soft profit. I venti anni che ci separano dalla “legge Ronchey” ci consegnano dati e conoscenze rilevanti, che vanno messe a frutto sulla relazione della gestione dei beni culturali con il mondo dell’impresa, sul quale le semplificazioni sono sconsigliabili: vi sono attività che producono margini, e molte altre che non lo fanno in termini economici, e dunque le interlocuzioni non vanno limitate ai soggetti lucrativi. Trattare con accuratezza queste diverse tipologie di soggetti e le modalità del loro coinvolgimento nei compiti di interesse generale significa anche cogliere sempre meglio gli effetti che il loro apporto può arrecare sul tema del pluralismo, che in materia culturale ha importanza non inferiore a quella che ha in materia politica, economica o sociale.
Lo statuto complesso e destrutturato della produzione artistica e culturale, della fruizione del patrimonio culturale e la sua relazione sempre più endemica con l'economia e l'apparato produttivo, con l'innovazione e l'industria, richiede capacità rinnovate di ricerca, di archiviazione, di messa in scena, di critica e comprensione, di visita e di contatto, ed una disponibilità alla connessione con luoghi altri, dove si implementano, si costituiscono e si utilizzano le conoscenze, o dove si producono beni e servizi, e persino una certa coscienza dei mercati e dei sistemi commerciali e finanziari. La dematerializzazione – di tanti prodotti umani ed anche – delle opere d’arte e culturali sta incidendo sempre più chiaramente non solo sulla struttura stessa del manufatto, ma su come viene fruito, trasferito, conservato, “esposto”, e dunque queste funzioni, anche per questa ragione, stanno mutando le proprie modalità di esercizio, con una sempre più necessaria attenzione all’archiviazione, alla catalogazione, alla esposizione digitali.
Occorre perciò riorganizzare l’autonomia e il radicamento territoriale dei luoghi culturali, soprattutto quelli statali, assai arrugginiti, che vanno gestiti (anche in gruppi) da organizzazioni rette da propri centri decisionali, con propri comitati scientifici, con un proprio bilancio, e con capacità di generare risorse finanziarie proprie, maneggiandole interamente in loco insieme ai sostegni pubblici dove necessari, con il coinvolgimento del territorio, dei residenti. Bisogna procedere a nuovi percorsi di formazione e selezione dei decisori museali, sempre più narratori, mediatori culturali, e dare spazio ad una nuova imprenditoria che voglia lavorare fuori dagli schemi soliti sui contenuti e sulla capacità evocativa di tutte le componenti del nostro palinsesto territoriale. E bisogna implicare tutte le discipline scientifiche utili ed appropriate, abbandonare ogni riduzionismo, accettare che è fecondissimo usare i saperi e le invenzioni provenienti dalle scienze dure come da quelle umane, sperimentare ogni complicità tra strumenti epistemici e operativi di ogni tipo.
Le attività dei musei devono poter rientrare tra quelle di carattere sociale e di ricerca, con ogni conseguenza, ad esempio, in tema di partecipazione ai sostegni finanziari, alle reti europee, alle regole degli appalti; occorre migliorare la qualità dei progetti (anche di gestione) e la capacità di selezionarli, così da essere più competitivi nel catturare fondi europei e più efficienti nella spesa pubblica e nell’attrazione di sponsor, mecenati, partners; si può, si deve concorrere a produrre un sensibile aumento dell’investimento nella produzione critica, dando modo ai tanti luoghi di ricerca e alle tante menti rilevanti di trovare strumenti di discussione e connessione rivolti al resto del mondo, ed una particolare attenzione va rivolta alle industrie tecniche, a quell’insieme di attività d’impresa – profittevoli o meno – strumentali alle attività rilevanti sulla cultura, che per tanto tempo, spontaneamente, sono state uno dei nerbi della produzione culturale italiana.
Va avviata una riflessione sulle modalità con cui è esercitata la tutela, incline ad un approccio, a dir così, dinamico, fruibile, utile, che riesca a coniugare le proprietà inemendabili dell’oggetto culturale con quelle, invece, epistemiche e narrabili, discutibili, attive con i linguaggi e gli strumenti di percezione di oggi; e che renda più possibili le connessioni con il mondo della ricerca e della produzione industriale. Lo strumento è già previsto dalla legge (Art. 17, comma 2 del codice), un decreto ministeriale di indirizzo in ordine alla definizione di criteri autorevoli, condivisi, ed uniformi per la catalogazione, la conservazione e la valorizzazione.
E infine sarebbe interessante trovare linguaggi e modalità di dialogo politico che, finalmente, lascino intendere che le responsabilità in cultura gravano sulla Repubblica (art. 9 Cost.), e dunque su tutte le sue componenti, istituzionali e sociali.
Rompiamo gli indugi, insomma, ed entriamo con entrambi i piedi nel XXI secolo.
Pierpaolo Forte, Università degli studi del Sannio. DEMM - Dipartimento di Diritto Economia Management e Metodi Quantitativi. Presidente Museo Madre.
© Riproduzione riservata