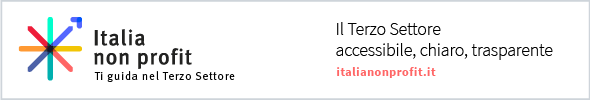RETI E SEGMENTAZIONE DEL PUBBLICO. MANAGER CULTURALI PRONTI ALLA SFIDA?
L'importanza delle «reti» per comprendere meglio il Paese. Le nuove forme di partecipazione culturale come antidoto all'esclusione e all'isolamento sociale. E un invito ai manager della cultura: lasciate perdere il generalismo, scegliete un pubblico di riferimento, coinvolgetelo e imparate a conoscerlo. Intervista ad Annalisa Cicerchia, Primo ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Statistica e professore di Management delle imprese creative all'Università di Roma Tor Vergata.
Rubrica in collaborazione con la Fondazione Marino Marini di Firenze
Nel Rapporto Annuale 2018, l'Istat ha introdotto una novità: la lettura della situazione del Paese attraverso la dimensione delle «reti». Cosa sono queste reti e che fotografia ci restituiscono dell'Italia in materia di partecipazione sociale e culturale?
Il Rapporto ci offre indicazioni sul valore che le reti hanno come fattore di protezione rispetto ad alcune grandi derive sociali del nostro tempo, a cominciare dall'isolamento degli individui. In genere, il livello d'istruzione è considerato come la più solida protezione dall'esclusione sociale. Da questo punto di vista, sappiamo che l'Italia presenta segni di arretratezza: il numero dei diplomati e dei laureati è molto basso e abbiamo il 47% di analfabeti funzionali, persone che sono in grado di comprendere il significato delle singole parole ma non quello dei periodi mediamente complessi. Si tratta di fattori molto potenti di esclusione e di blocco di mobilità. In attesa che si risolvano questi problemi – e prima o poi lo si dovrà fare – le reti intervengono come possibile alternativa. Quando le persone sono incluse in reti di tipo non strettamente familiare o di vicinato – anche se risiedono in zone disagiate, appartengono a gruppi sociali svantaggiati o hanno livelli d'istruzione più bassi – esprimono una partecipazione culturale in linea con quella degli individui più colti, agiati, che vivono nelle migliori condizioni geografiche e urbanistiche. Questo discorso è ancora più evidente nelle reti di tipo altruistico, legate a forme di volontariato.
Perché avete deciso di guardare alle reti?
L'Istat non si limita a raccogliere grandi quantità di dati, ma cerca di offrire anche gli strumenti per integrarli e permettere nuove letture. Abbiamo cominciato nel 2015, proponendo una visione del territorio più sofisticata rispetto a quella tradizionale per confini amministrativi. Quindi, in occasione del novantesimo compleanno dell'istituto nel 2016, abbiamo aggiunto una diversa lettura su scala temporale, agganciando ai riferimenti delle persone e delle famiglie anche una chiave generazionale. Adesso è la volta della dimensione delle reti. Sono esercizi con cui non inventiamo nulla – le reti naturalmente c'erano già prima – ma offriamo un pezzettino in più di comprensione.
Si può affermare che le reti contribuiscano direttamente ad aumentare il livello di inclusione sociale e culturale?
Noi ci limitiamo a osservare e non possiamo stabilire rapporti di causa/effetto: quello è compito dei sociologi. Si può però notare che chi fa parte di reti altruistiche tende a mostrare livelli di partecipazione e di soddisfazione più elevati rispetto a chi non ne fa parte. Anche dal punto di vista della percezione del proprio stato di salute. Sul perché, entriamo nel gioco delle ipotesi. Io posso immaginare che se una persona fa volontariato in un ospedale, alla Caritas o in un altro ambiente sociale, probabilmente entra in contatto con persone che normalmente nella sua esperienza non potrebbe frequentare. In un paese come l'Italia – dove non esistono più ascensori in salita e si tende a essere condizionati dal luogo in cui si lavora, dall'istruzione ricevuta, dal quartiere dove si abita – le reti ti permettono di ampliare conoscenze e contatti. E uscendo di casa eviti anche l'impoverimento del linguaggio e delle conoscenze che deriva dall'isolamento.
Però oggi molte persone partecipano a un tipo di reti, quelle «digitali», anche rimanendo in casa.
Nel Rapporto c'è un capitolo molto ampio dedicato alle reti digitali. Quello che emerge è che – in tutti i casi – una rete digitale non sostituisce una rete fisica, e viceversa. Sono complementari.
I livelli di inclusione ed esclusione culturale variano molto dal punto di vista geografico?
Moltissimo. Sia dal punto di vista dell'offerta che della domanda. Variano la dotazione disponibile sui territori, il modello di partecipazione, la distribuzione per gruppi sociali. Dal rapporto emergono diversi tratti nei consumi culturali. Gli ascoltatori della radio, per esempio, sono spesso quelli che abbiamo definito «giovani blue collar», mentre tra i cosiddetti «pensionati d'argento» sono più diffusi concerti di musica classica ma anche prodotti a basso costo come i libri. La partecipazione culturale digitale invece è molto diversa all'interno della stessa classe sociale: più alta nelle famiglie a basso reddito straniere che in quelle italiane. A tutti questi aspetti si aggiungono e si intrecciano le differenze territoriali. Di volta in volta, la profilazione ci presenta aspetti molto più complessi rispetto a una banale suddivisione per età o per aree geografiche come «nord», «centro» e «sud».
Lei insegna management delle imprese culturali e creative: quale lezione innovativa possono trarre i manager culturali dalle osservazioni incluse nel Rapporto?
Rispondo da professoressa, più che da ricercatrice. Primo: segmentare la domanda. Secondo: smettere di guardarsi l'ombelico. Il punto fondamentale è una profonda revisione della propria proposta di valore, partendo dal presupposto che essa non è mai assoluta e non può essere legata solo a chi la eroga. La proposta di valore deve tenere conto del destinatario, che non è l'utente, il turista o il consumatore culturale generico, semplicemente perché queste figure non esistono. Il manager culturale deve studiare, scoprire e scegliere nella micro-segmentazione del pubblico; deve individuare il soggetto che ha davvero bisogno di ciò che propone. Naturalmente, questo significa partire dalla consapevolezza che non potrai mai andare bene a tutti. Se tu pensi che la tua offerta sia buona per chiunque e ti limiti ad aspettare che il pubblico venga da te, sarai condannato all'estinzione.
Su questi temi, qual è il livello di consapevolezza tra gli addetti ai lavori in Italia?
Il settore è molto vasto, ci sono tante situazioni – e tradizioni – differenti. Sono numerose le imprese culturali, anche individuali, artisti compresi, dove c'è molta difficoltà ad accettare l'idea di scendere a un compromesso.
In diversi comparti si fatica ad abbandonare una visione autoreferenziale.
Per esempio?
Preferisco soffermarmi sui modelli virtuosi. I musei stanno facendo uno sforzo enorme. Gli esempi sono numerosi. A Torino c'è una realtà come il Polo del '900, dove si è creata una situazione particolarmente felice: la direzione di Alessandro Bollo, una persona che conosce molto bene i temi di cui stiamo parlando, è sostenuta da una governance che ne condivide la visione e l'approccio. Al contempo, esistono tantissime realtà in cui non c'è questa coincidenza: strutture dove la testa della governance e il cuore curatoriale vanno in direzioni opposte. Altri settori, come quello della musica classica e del teatro più convenzionale, stanno soffrendo molto. Parlando di inclusione, poi, c'è un'enorme forma di miopia nei confronti della popolazione anziana. È un dato di fatto che l'Italia è un paese sempre più vecchio, oggi ci sono oltre 13 milioni di anziani e a volte sembra che le istituzioni culturali non si curino di loro. Io sono felicissima quando leggo di iniziative dei musei, delle biblioteche o dei teatri per bambini e giovani – non sono mai troppe! – ma mi piacerebbe che lo stesso venisse fatto per gli anziani, anche se sono meno facili e malleabili dei bambini.
Come potrebbero essere coinvolti?
La parola chiave è proprio quella: coinvolgerli. Non mi sembra che lo si stia facendo. Prendiamo le biblioteche: nel complesso sono straordinarie, sia quelle dei grandi centri metropolitani che quelle che servono paesini di cinquecento abitanti, però se vai a vedere le loro iniziative e i loro spazi, scopri che si punta soprattutto su bambini e ragazzi. In Inghilterra, quando entri in una biblioteca ti trovi già vicino all'ingresso uno scaffale pieno di libri scritti a corpo grande, per le persone che hanno problemi di vista! Tra l'altro, la popolazione anziana non è solo enorme ma è anche molto diversificata: ci dovrebbero essere iniziative specifiche per i settantenni, per gli ottantenni, per i novantenni. Tutte fasce anagrafiche che probabilmente non hanno solo una maggiore predisposizione alla lettura, ma anche un reddito superiore a quello dei propri nipoti.
A proposito di invecchiamento, istituzioni come le biblioteche, i musei e i teatri non si presentano nel nuovo millennio un po' appesantiti dalla loro storia plurisecolare?
Credo che il problema non stia nei nomi o nella storia, ma nei progetti che portano avanti. Esistono iniziative molto belle e innovative in Toscana, rivolte a una delle categorie maggiormente rimosse dall'offerta culturale: i malati di Alzheimer. Musei ipertradizionali che offrono a queste persone modelli di fruizione nuovi e moderni. Si torna al ruolo del manager culturale, che non è poi così diverso da quello del ricercatore medico che ha appena inventato un nuovo farmaco e deve sapere con precisione a quale patologia si rivolge, dunque quale paziente ne ha bisogno. Con la cultura il discorso è simile. Il manager deve pensare: io ho tra le mani questa cosa incredibile, funziona benissimo... ma per chi?
Torniamo al punto di prima: più nicchie e meno mainstream. Un approccio meno generalista.
Il generalismo è letale: è solo un modo per dimostrare che non ti importa niente del pubblico. In Italia, poi, è tanto sopravvalutato quanto inefficiente: è già tanto se le istituzioni culturali «generaliste» per antonomasia raggiungono il 32 o 33 per cento della popolazione. Sette italiani su dieci rimangono fuori. Inseguendo un presunto generalismo, tutto ciò che ottieni è l'effetto opposto: raggiungi una quota nettamente inferiore delle persone che potrebbero trarre benefici dalla tua proposta. Bisogna avere il coraggio di scegliere, puntare su categorie precise e costruire con il pubblico un rapporto che vada al di là del mordi-e-fuggi. Se riesci a sviluppare una relazione speciale con le persone, a creare una forma di comunità, le persone torneranno da te più spesso.
Si tratta di un modello sostenibile anche dal punto di vista economico?
Molto sostenibile! Se un luogo diventa «mio», se so che posso andarci sempre e che senza di esso mi sentirei meno felice, allora ci tornerò volentieri. E probabilmente sarò ben contenta di aiutarlo anche economicamente.
Spesso le istituzioni culturali pubbliche vengono valutate sul mero numero degli ingressi.
Dovremmo iniziare a guardare anche altri parametri. Per esempio, il tempo che i visitatori trascorrono dentro a un museo o a qualsiasi luogo della cultura. Anche quello è un indicatore quantitativo. In Italia ci sono spazi come le biblioteche che si sono storicamente attrezzate per diventare luogo di ospitalità, dove magari si va a studiare quando si vuole stare tranquilli e lontani dagli smartphone. Nei musei purtroppo siamo ancora indietro: nella maggior parte non entri per «stare», ma solo per «vedere» qualcosa.
In Europa le cose vanno meglio?
Dipende da quale aspetto si guarda. Di sicuro l'Italia è molto indietro sul digitale: abbiamo ancora troppe strutture che arrancano o addirittura vedono il digitale come una diavoleria moderna. Siamo invece ben messi per quanto riguarda la gestione del patrimonio. D'altronde, il Ministero dei Beni Culturali si occupa soprattutto di quello: restaura, conserva e tutela il patrimonio culturale. Lo si potrebbe definire il «modello Piero Angela» ed è qualcosa in cui siamo bravissimi, avanti anni luce rispetto ad altre aree in Europa. Il problema è che in altri comparti non siamo coperti da nessun ministero. In certi comuni, gli assessorati nascono e sopravvivono solo grazie ai fondi europei. E quando una zona è orfana, non presidiata, come per esempio quella dell'innovazione culturale, lo si vede subito.
Qual è la lacuna più grave?
Non conosciamo il pubblico. È buffo: viviamo in un'epoca in cui il supermercato si accorge che mi è morto il gatto perché vede sugli scontrini che non compro più le crocchette e non siamo in grado di dire se al cinema o in un museo entrano spettatori maschi o femmine. Eppure quello è un aspetto fondamentale dell'innovazione nelle pratiche culturali: sapere chi è il tuo pubblico. Purtroppo in Italia siamo reduci da un'ubriacatura che è durata tanti anni, nei quali ci siamo illusi che la cultura fosse roba da turisti: contava solo attirarne tanti. Con il risultato che oggi a Venezia, Firenze, Roma e Pompei sono tutti preoccupati dall'over-turismo.
Qual è invece un progetto innovativo virtuoso su cui si sta lavorando in Italia?
È molto interessante il tentativo del Ministero dei Beni Culturali di superare la storica differenza tra i musei statali, appena 439, e quelli non statali, circa 5.000, per creare un sistema nazionale museale unico. È qualcosa che servirebbe anche ai teatri, che viaggiano ognuno per conto proprio. Non sarà semplice, perché ci sono musei diversissimi per dimensioni, risorse, modelli di gestione, ma potenzialmente è un esempio virtuoso di rete. Ed è la prova che ci vuole sempre una strategia. È molto difficile lavorare se non c'è qualcuno che se ne fa carico, promuovendo e investendo nell'innovazione.