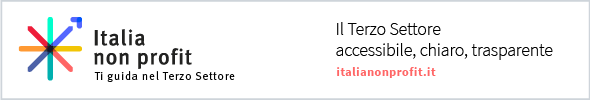I talebani dei beni culturali
La nomina di un ministro Carneade ha alquanto spiazzato gli esponenti ufficiali e ufficiosi della cultura italiana che probabilmente avrebbero voluto ricevere quell’incarico. Ci prendiamo la libertà di chiamare irrispettosamente Carneade Massimo Bray perché lo conosciamo. Abbiamo lavorato insieme un paio d’anni, quando la nostra casa editrice realizzò per la Treccani (di cui Bray era il capacissimo direttore editoriale) un Dizionario dell’architettura del XX secolo in quattro volumi. Lavorare a un’opera di quella complessità (della quale non esiste equivalente al mondo) è uno dei modi migliori di capire la stoffa di una persona. Bray ha un’esperienza diretta praticamente totale, collaudata durante decenni, dei massimi esponenti della cultura italiana, scientifica e umanistica, cioè di coloro (centinaia anzi migliaia) che hanno collaborato alle Enciclopedie Treccani. Ne conosce talento, capricci, debolezze, ambizioni. Nessuno ne conosce tanti e così bene quanto lui. Se il ministro dovrà utilizzare questa «materia prima», Bray parte avvantaggiato perché sa valutarla meglio di chiunque altro. Bray, avendo dovuto fare un lavoro complesso che doveva produrre un risultato concreto, irreprensibile, perfetto, sa quanto un lavoro di qualità sia complicato, faticoso e rischioso: la sua è un’esperienza operativa pratica di cui quasi tutta la classe politica è a digiuno. Bray inoltre sa che questo prodotto deve essere venduto, deve piacere, deve servire. Anche questi requisiti e obiettivi sono ignoti alla classe politica vigente. Anche molti studiosi dediti a quella esperienza incontrollata, incontrollabile e teorica che è l’insegnamento non ne sanno nulla. Meraviglioso compito, ma spesso privo di verifiche concrete, di conseguenze e responsabilità accertabili sugli effetti. Un lavoro quasi sempre lontano dalla realtà. Chi ha scelto Bray è stato bravo a evitare tutte le lusinghe delle vanitose sirene e degli astri gloriosi del mondo della cultura, optando invece per chi lavora e chi sa far lavorare. Una scelta seria, dunque. Vediamo se produrrà frutti. Anche perché un ministro può pochissimo o nulla se non coinvolge l’intero collegio governativo. Il mondo della cultura, dicevamo, ha invece reagito in modo scomposto alla scelta inattesa di un estraneo, fuori dalle corporazioni. Per esempio, dopo aver tuonato contro i tagli, si è indignato che il ministro della Cultura lo fosse anche del Turismo. Ignorando che non solo è una esigenza di sopravvivenza per milioni di italiani, ma che se i soldi non ci sono, bisogna trovarli. E il modo più serio e logico è trovarli con il lavoro che i beni stessi di cui disponiamo (patrimonio e paesaggio) possono produrre senza essere consumati o lesionati. Con l’offerta turistica. È stupefacente che non abbiano capito che, nelle condizioni in cui siamo e che non possono venire ignorate, avere un ministro di entrambi, patrimonio e turismo insieme, se il ministro è stato scelto bene, è l’unico modo per procurarci le indispensabili risorse ed evitare che le avidità turistiche possano generare scempi e devastazioni nel paesaggio e nel patrimonio. Certamente più di quanto riuscirebbe a fare un ministro, per quanto puro e incontaminato, che debba però contrapporsi a un altro ministro, probabilmente portatore di interessi opposti, magari privo di una base culturale adeguata per capire l’importanza di quanto sia tassativo valorizzare e preservare questi beni anche per il futuro. Perfino il tutore numero uno del nostro patrimonio artistico, Salvatore Settis, è rimasto disorientato. In un articolo intitolato «Usciamo dalla notte dei beni culturali» («la Repubblica», 6 maggio) ha espresso il panico per una «privatizzazione strisciante» citando paradossalmente esempi opposti al suo timore, comportamenti illuminati come quello di David Packard per Ercolano e quello della Fondazione Carige per l’Accademia Ligustica. Ha ricordato l’invidiabile, esemplare realtà del National Trust inglese, prova di come una virtuosa collaborazione con i privati non sia impossibile, per concludere tuttavia che non sarebbe imitabile in Italia per uno strano motivo: perché abbiamo già la più antica legislazione protettiva del mondo. Ma abbiamo anche una scassatissima struttura ministeriale i cui risultati nessuno oserebbe difendere, al di là della competenza e dedizione degli addetti. Settis invoca «nuovi investimenti, nuova immaginazione e nuova competenza», ma non dice come e dove trovarli e critica invece l’industriale Della Valle perché non ha voluto staccare semplicemente un assegno, ma ha osato pretendere garanzie e contropartite per finanziare il Colosseo.
Addirittura disturba il fatto che qualcuno affronti il toro per le corna come nel caso delle ipotesi di un collaboratore ospite del Giornale dell’Arte (aprile 2013) piene di buon senso, di affidare la tutela a grandi esperti, anche internazionali (questo inquieta il nostro establishment nazionale), che facciano capo a un’Autorità stabile sottratta al rischio di ministri impreparati, inadatti e sottoposti a contingenti logiche politiche come per esempio l’impressionante triade Bondi-Galan-Ornaghi (che Settis stesso critica), ma che sia invece controllata dalla Presidenza della Repubblica (come la Magistratura o le Forze Armate), e di lasciare invece al ministero politicizzato la sola gestione delle attività contingenti (mostre, celebrazioni, spettacoli e compagnia bella), sottoposte ad appetiti di demagogia spicciola e territoriale.
Il nostro giornale si è beccato l’accusa di «favoleggiare» per aver osato ospitare una proposta, innovativa e fondata del tutto degna di essere approfondita, per estirpare difetti che tutto il mondo rimprovera al nostro Ministero. E ci accusa di aver «brindato da partigiani del privato» quando l’ipotesi che abbiamo ospitato è invece esattamente l’opposto, senza alcuna controposta, se non un arroccamento su posizioni di intransigente conservatorismo e immobilismo.
Molto bene ha reagito l’editore Cesare De Michelis («Corriere della Sera», 17 maggio) che ha rimproverato questo abbandono di qualsiasi «speranza di quel cambiamento che tutti ci auguriamo (…)condannando la cultura italiana a rimanere ancella di un potere governativo che ha dato sinora bastanti prove di considerarla con disattenzione e disinteresse. (…) Per la cultura in Italia, prima di qualsiasi incremento delle risorse, è urgente e necessario mettere mano a una riforma radicale del sistema esistente, che a partire dalla struttura e dai compiti del Ministero per i Beni culturali investa teatri, musei, biblioteche e archivi, attribuendo a ciascuno un’autonomia gestionale che li obblighi a misurare costi e benefici, a tener conto della domanda degli utenti e a coinvolgere nell’attività il territorio, le scuole, le imprese; è indispensabile, insomma, più attenzione al mercato e alle sue regole e un maggior coinvolgimento di operatori privati». Come dargli torto? Forse vi è chi teme di «perdere, invece, quegli antichi modelli “giacobini”, che da sempre pretendono di sapere meglio degli utenti quello di cui loro avrebbero bisogno: la disaffezione del pubblico verso la cultura di Stato conferma ogni giorno la distanza che resiste tra la domanda e l’offerta e l’inadeguatezza della seconda rispetto alla prima». Purtroppo tacciare di «strisciante privatizzazione» quanto non proviene da una ristretta élite appare come la difesa di un diritto delegato ed esclusivo di partecipare e di contribuire alla salvaguardia del patrimonio artistico e del paesaggio. Ma quel patrimonio è di tutti, come sostiene la Costituzione più volte invocata. Dunque è giusto che tutti, privati e non, siano chiamati a farsene carico, a collaborare con i tecnici collaudati ai quali soltanto spetta questo delicatissimo compito. Sbaglia la minoranza talebana se invece dimostra insofferenza verso gli apporti di terzi, in particolare privati, quasi fossero intromissioni intollerabili nei riti iniziatici di una setta esclusiva. In fondo un ente privato come il National Trust funziona incomparabilmente meglio di un Ministero pubblico come il nostro.