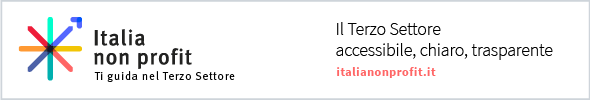Fondazione culturale? Sì, a patto che aggiunga valore
Oggi, sempre di più, si parla della cosiddetta «moda fondazionale»,che affida alla scelta della forma giuridica istituzionale la possibilità di innovare la gestione dei beni e delle attività culturali.
Ci chiediamo, dunque: la fondazione è davvero la soluzione ai tanti problemi del sistema culturale italiano? O è meglio prima di tutto ragionare sulla strategia e sul modello gestionale che, fatto salvo il ruolo dello Stato, ricorra a soggetti idonei ad assicurare efficaci ed efficienti risposte alle urgenze del nostro patrimonio? Cosa deve prima di tutto chiedere il settore culturale al privato: finanziamenti o un nuovo modello per gestire il proprio patrimonio?
È difficile giudicare tout court un modello assai articolato e variamente impiegato in ambito culturale, come quello della fondazione. Oggi, però, possiamo almeno avere un’idea più chiara circa la fisionomia che le fondazioni culturali hanno assunto (mi riferisco in particolare a quelle operative, trascurando le grant-giving su cui andrebbe fatto un ragionamento a parte), concentrandoci sul ruolo originario e, soprattutto, sulle opportunità di un loro efficace impiego e rinnovamento.
Interrogativi in qualche modo accentuati dai recenti provvedimenti governativi (c.d. «spending review»).
Esaurita la fase in cui la fondazione in sé appariva essere la soluzione di governance più efficace agli annosi problemi di programmazione e buona gestione (ispirata ai ben noti principi di efficienza, efficacia ed economicità), oggi si riscontra una maggiore prudenza, motivata anche dalle critiche che spesso le fondazioni (soprattutto quelle di partecipazione Statale) hanno attirato.
Rispetto alla tua domanda, ritengo che la fondazione, nel confronto con una gestione diretta da parte della PA, è potenzialmente in grado di assicurare una maggiore responsabilizzazione del personale, attraverso una corrispondenza chiara tra risultati della gestione e politiche di valutazione e incentivazione; può al contempo favorire una strutturata partecipazione dei cittadini alla definizione, realizzazione e valutazione di progetti e programmi culturali; può costituire un valido contesto di favore fiscale attraverso cui veicolare risorse private, anche estere (un programma nazionale di attrazione degli investimenti esteri centrato sulle fondazioni culturali italiane sarebbe sì una bella sfida di politica economica, arricchendo a mio avviso il ristretto set di strumenti del c.d. marketing territoriale).
Si potrebbe obiettare che queste finalità, anche congiuntamente, sono perseguibili da una PA diversamente organizzata, con migliori e maggiori risorse, con minori vincoli, ma è innegabile che oggi si pone una questione cruciale: quanto tempo abbiamo davanti per riformare – in modo definitivo – l’offerta culturale italiana, soggetta a continue revisioni e alterne logiche, che ne sovrintendono il funzionamento, e che, quando divergenti, ne minano la credibilità complessiva?
In breve, non si vede oggi un disegno organico, fosse esso di gestione diretta, di articolazione su più livelli dell’intervento pubblico (attraverso società anche commerciali, ma gestite direttamente), o di assetti nazionali, provinciali o civici, che renda inutili le fondazioni, che peraltro anche nel resto d’Europa continuano ad essere un perno fondamentale del settore culturale. E pertanto a mio avviso bisognerebbe soffermarsi, piuttosto, su strumenti e incentivi che possano renderle sempre più efficaci, con regimi fiscali di vantaggio ancora più ampi, includendo anche attività commerciali strettamente attinenti alla valorizzazione culturale, così da promuovere davvero una nuova economia della cultura, che non sia finanziata, ma sostenuta attraverso incentivi che premino la libera iniziativa dei cittadini, accrescendone così anche il senso di appartenenza.
Ciò che pare necessario, alla luce di quanto accade nel settore culturale italiano, da Brera al MAXXI, per citare i casi più recenti, è un maggiore controllo non tanto verso l’istituto giuridico della fondazione, quanto verso un settore in cui è sempre più urgente l’apporto di risorse, ma anche di competenze e l’applicazione di nuovi modelli gestionali e finanziari.
A tuo parere quali sistemi di accountability dei risultati economici e sociali possono essere attivati? Nel caso delle fondazioni, come valutare la coerenza dell’operatività con la missione dichiarata e il rispetto del vincolo economico, finanziario e patrimoniale?
Concordo sul fatto che l’attenzione vada spostata dagli istituti giuridici, che comunque sono e dovrebbero rimanere mezzi e non fini, al settore, perché inevitabilmente i casi da te citati hanno suscitato in ogni cittadino interrogativi legittimi circa l’opportunità del dibattito, e il livello adeguato di influenza (ingerenza) del Ministero rispetto ad un soggetto «autonomo». Il tema dell’accountability può avvitarsi attorno ad un complesso insieme di strumenti, perché, come ci ricorda la l. 150/2009, solo attraverso l’integrazione della programmazione, della trasparenza e della valutazione, è possibile migliorare la qualità dei servizi e la fiducia dei cittadini. Per evitare di complicare troppo la questione, credo che due elementi siano sufficienti nel breve termine: misurazione e trasparenza. Superata, speriamo, la stagione retorica dei «giacimenti culturali», oggi abbiamo l’obbligo di capire (proseguendo nel solco di questa metafora un po’ bruttina) se abbiamo, che forma hanno e che risorse richiedono le «piattaforme per estrarre» il petrolio. Avremmo molto apprezzato una vera spending review del settore culturale, con obiettivi chiari e misurabili per tipologia di bene, o di istituto. Una spending review, di stile britannico, che legasse i finanziamenti alle performance, anche nel settore culturale, che non scadesse nel misurare il valore attraverso i ritorni al bookshop, ma che certamente includesse l’accessibilità e la conoscenza del sito da parte del pubblico come elemento fondante della valorizzazione (come peraltro la DG Valorizzazione del MiBAC ha ben compreso, con interventi ad hoc); dare degli obiettivi di crescita (espliciti e vincolanti) per un luogo o istituto di cultura non può più essere un tabù, con l’alibi (quante volte ce lo siamo sentiti dire?!) che «meglio non arrivi troppa gente» o che «la cultura ha un valore inestimabile» (vero!). Ma la qualità dell’organizzazione dell’offerta culturale, quella invece è misurabilissima. Così come misurabile è la capacità di carico di un sito per orientare le destinazioni d’uso degli spazi, anziché lasciare queste, come mille altre questioni, ad estenuanti dibattiti senza punti fermi e dati oggettivi. Insomma, speriamo che l’agenda OpenData abbia riflessi sul settore, e che arrivino esperienze davvero interessanti, low cost, e che si diffondano. Basterebbe in fondo partire con obiettivi chiari, azioni conseguenti e misure condivise (si veda il funding agreement tra V&A Museum e DCMSI, adattabile e replicabile anche in contesti molto piccoli).
Il caso di Brera fa riemergere un dibattito, che sembra non trovare soluzione. Da un lato c’è chi sostiene che una fondazione aiuterebbe a risolvere i problemi della Pinacoteca, dall’altro cresce il numero dei firmatari della lettera al Presidente della Repubblica e al premier contrari all’ingresso dei privati. Quale soluzione, a tuo parere, è prospettabile per risolvere tali contrapposizioni?
Perché non spostare il dibattito sulla necessità di una privatizzazione non tanto formale, quanto sostanziale delle istituzioni culturali, tale da renderle sempre più in grado di affiancare al finanziamento pubblico il contributo di privati e i ricavi propri generati dalla qualità e dalla quantità dell’attività svolta?
Un dibattito molto acceso, è vero; e molto attuale: è di qualche giorno fa l’interrogazione parlamentare dell’on. Di Pietro circa l’art. 8 del decreto-legge n. 83, quello che appunto riguarda il progetto c.d. Grande Brera. La fondazione, che in questi giorni sta vedendo la luce almeno sul piano degli incontri istituzionali, avrà la forma di fondazione di partecipazione e dovrà pianificare il raddoppio della Pinacoteca, realizzare il polo museale di Palazzo Citterio e costruire il campus dell'Accademia nell'ex distretto militare di via Mascheroni. L’accordo e la soddisfazione delle parti in causa (Comune, Regione, Fondazione Cariplo e Camera di commercio, oltre che il MiBAC) credo sia un buon segno, testimonianza di una sincera volontà di impegno. Rimane il tema, sempreverde, del complicato rapporto tra risorse e prerogative di eventuali privati. Considerando il peso assoluto della componente pubblica, almeno stando alle notizie più recenti, non credo che la privatizzazione sia un rischio reale, a meno di non considerare la natura privata dell’istituto così determinante, e non mi pare il caso. Ritengo al contempo interessante, tra gli elementi portati all’attenzione della UIL (contraria al progetto di fondazione), l’ipotesi di modifica normativa che consenta, anche nel caso di un Polo autonomo, una partecipazione strutturata dei privati. Mi sembra una strada meritevole di attenzione; una volta chiarite le caratteristiche di questi due modelli, si potrebbe perfino auspicare una valutazione trasparente dell’una o l’altra formula (come peraltro richiamato dal Codice all’art. 115) per giungere ad una scelta condivisa. In generale non sono contrario alle fondazioni, per quanto detto prima, a patto che esse aggiungano significativo «valore», e che non siano un sostituto della Pubblica Amministrazione ad un costo maggiorato per la collettività.
Massimo Sterpi, sulle pagine de Il Giornale delle Fondazioni, afferma provocatoriamente che«piccolo è brutto», descrivendo un sistema a suo parere perverso, fatto di«micro-fondazioni nelle mani dei privati fino a quando essi potranno avere una convenienza fiscale a gestirle, per trasferirne gli oneri agli enti pubblici non appena la fase «privatistica» si sia esaurita». La sua riflessione si conclude con l’idea che «la cultura non ha bisogno di ulteriori norme di agevolazione fiscale (che, al limite, sono addirittura troppe), ma di progetti di alto livello». Cosa ne pensi?
Penso che la provocazione richiami il noto problema della massa critica che le fondazioni devono raggiungere per assicurare buoni livelli di gestione e efficacia di intervento. Rimane tuttavia il problema, ben noto ad esempio ai gestori di fondi (asset management), che la scelta ottimale della scala deriva da una serie di questioni tecniche, connesse agli strumenti che si intendono impiegare e alle attività da svolgere; e purtroppo, queste analisi non sono disponibili per le fondazioni culturali, che, al pari di altre forme giuridiche del settore, non sono purtroppo al centro di programmi di ricerca adeguati (come è avvenuto e avviene invece, ad esempio, per le fondazioni bancarie). Forse, e anche questa ipotesi dovrebbe essere vagliata empiricamente, si potrebbero configurare delle specializzazioni funzionali, assegnando (attraverso incentivi) ruoli diversi alle grandi fondazioni (generalmente attrattive verso grandi aziende) ed alle piccole (a volte più capaci di aggregare il fondamentale contributo del volontariato culturale).
Circa un’ipotetica normazione di vantaggio, in effetti mi pare che il quadro sia abbastanza definito, e piuttosto mi concentrerei, anche in questo caso, sulle attività che esse svolgono, premiando, con provvedimenti puntuali, quelle attività economiche che rafforzano la valorizzazione, suscitando così una economia di impresa connessa al patrimonio culturale, come peraltro suggerito dai nuovi indirizzi comunitari oltre che dalle migliori esperienze italiane.
© Riproduzione riservata